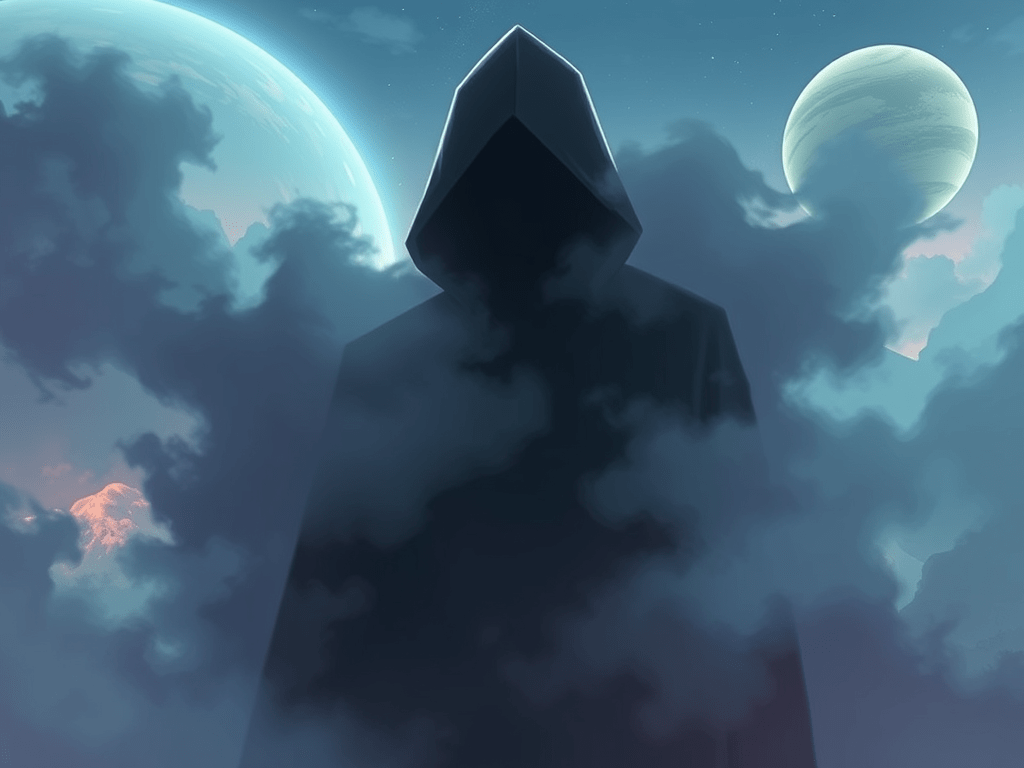A me stesso, soprattutto.
Sarebbe facile, liquidare così la questione; troppo, comodo e senza complicazioni: di coscienza.
Sconosciuto, cioè colui che non si conosce, che non si è mai visto: gente sconosciuta, quando, ad esempio, si esplorano – è ancora possibile – nuovi territori, nuove realtà, nuovi pianeti.
Tante eccezioni, anzi, accezioni; tante sfumature, come spesso regala e certifica la nostra amata, sconosciuta – per restare abbarbicati al tema – ai più (lo scrivente, in testa), lingua italiana.
Potessi optare, diventerei un illustre sconosciuto; sconosciutamente, me ne andrei con pochi, fidatissimi compagni (per citare, fintamente colto, il Boccaccio).
Mi piacerebbe essere un personaggio della letteratura disegnata, lo Sconosciuto di Magnus – Satanik e Alan Ford dovrebbero dire qualcosa, smuovere l’immaginazione, agitare fumettose rimembranze – , alias Roberto Raviola; celebrato giustamente con una fortunata mostra monografica al Paff, Palazzo delle Arti e del Fumetto di Portus Naonis, l’autore bolognese, svincolatosi dall’impegno pressante della serialità, offre al pubblico uno spaccato degli anni ’70 (del 1900, per il puntiglio), attraverso le vicende e gli occhi di un disincantato, di un cinico, di uno sconfitto, che sulla propria pelle vive, e registra, non come uno storico o un romanziere classico, gli interessi e le trame occulte che in quel periodo agitano l’Italia e lo scacchiere internazionale; con un tono vagamente, volutamente pulp.
Sconosciuto, il mio destino: per fortuna. Meno bene, sconosciuto il saper (come) vivere; meglio, il senso della vita. Da vecchi, o in viaggio non commutabile, su quel sentiero: fatto ingiustificabile, intollerabile.
Mi sovviene, curiose associazioni mentali, lo Straniero e non so quali, o se esistano, attinenze tra i due personaggi; in caso affermativo, sono ignote, a me stesso, acclarato ignorante totale. Ignote, eppure presenti, ravvisabili, tangibili, solo con la mente e suoi derivati. Premesso, ammesso funzionino: correttamente.
Scavo, scavo archeologicamente nella memoria, meglio di quanto farebbe Heinrich Schliemann – chi fu, costui? – per rintracciare, per rinvenire (non svenire), per recuperare indizi, orme, schegge di selce, di me, del mio passato, appurato che del futuro – posteriore, anteriore o meno – non detengo nemmeno prelazioni, certezze. La verità, una delle poche cui possiamo accedere, riguarda la memoria: lungi dall’essere un archivio fotografico, lungi dall’essere uno sterminato archivio di informazioni, “è un delicato sistema ricostruttivo che vive di equilibrio tra ricordare e dimenticare“. Lo assicura Sergio Della Sala, professore di Neuroscienze cognitive umane presso l’università di Edimburgo. La dimenticanza non è poi così grave, riflettendoci un po’. Magari improvvisando danze tradizionali scozzesi, per stimolarne, a seconda del ritmo, maggiore o minore vigoria. Della dimenticanza.
Purtroppo, esistono anche realtà fastidiose, non sconosciute, almeno dal 1972, ma che noi, intesi come popolazione mondiale, vogliamo abbandonare nell’ombra, possibilmente rimuovere, in fretta e per sempre. In tale categoria, a pieno titolo, cito il meritorio Rapporto sui limiti dello sviluppo, “terrificante oracolo” – come scrivono i tipi de La Lettura del Corriere della Sera – che anticipò di decenni il ‘vaticinio di Cassandra’ sui modelli di sviluppo e crescita economica senza limiti, che ci hanno condotti sull’orlo della catastrofe finale. Il transalpino Abel Quentin narra la storia e le vicissitudini dei fantastici quattro (Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens III) che misero in allerta l’umanità riguardo i pericoli esiziali del nostro modo di abitare il pianeta e di sfruttarne le risorse; lo fa con leggerezza, per quanto possibile, e con una sana dose di umorismo. Lo fa, bene, in forma di romanzo, ma non c’è, davvero, niente da ridere.
Ormai sappiamo che “per innescare un ruolo“, consapevole e attivo, in chi ascolta brutte notizie, la strategia più indicata, risiede nella capacità di porre domande interessanti, anzi, giuste;
certo, per scongiurare la fine del mondo, temo ci si debba ingegnare come mai, prima d’ora.
Intonare A che ora è la fine del mondo? e impugnare una ramazza di saggina, potrebbe non risultare sufficiente;
ma si può tentare: potrebbe essere l’inizio:
per non essere più sconosciuti, umanamente, a se stessi.