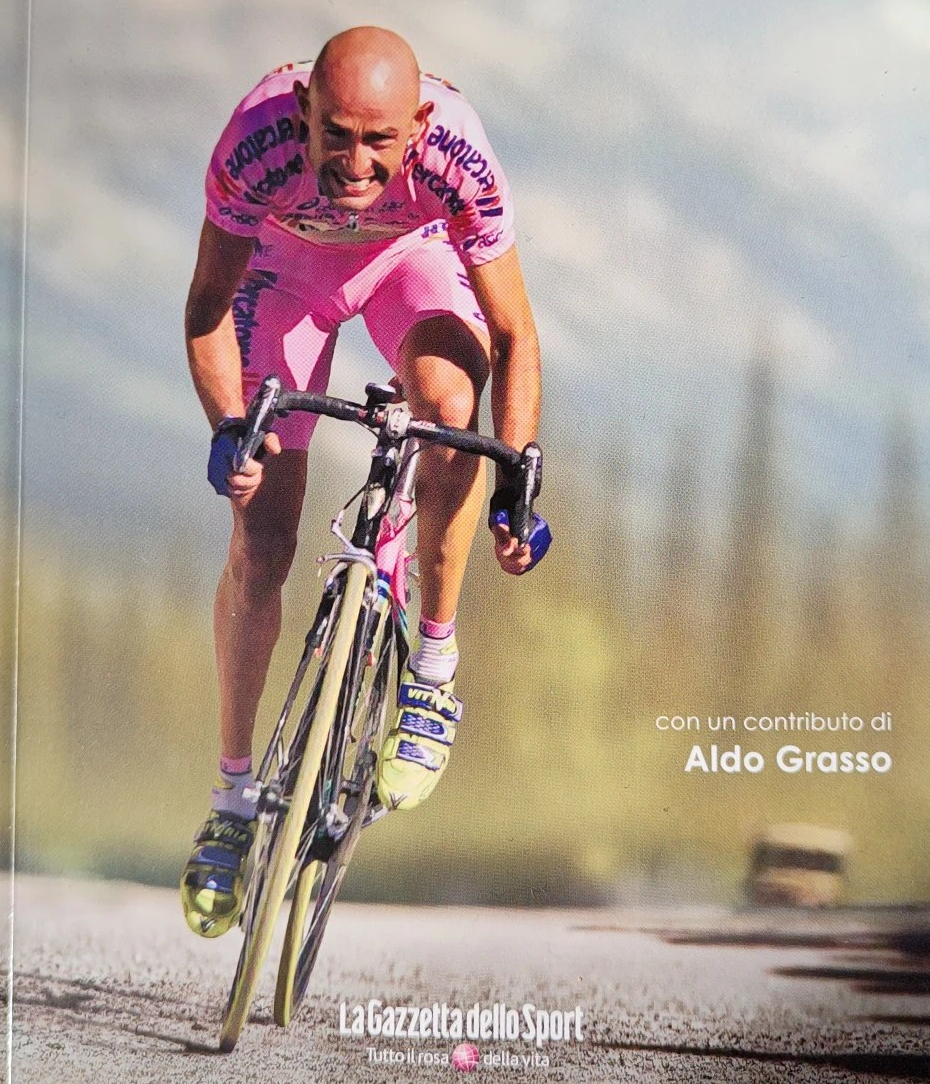Vago nella nebbia, perso come un lampione sulla riva del fiume, cercando i colori; altri colori.
Un vecchio sapiente ci racconta che i colori conosciuti e disponibili a partire dagli incerti albori dell’umanità erano sostanzialmente tre (3): il nero della cenere una volta capita l’importanza e l’accensione del fuoco, l’ocra della terra (giusto per non obliare da dove siamo nati e cosa torneremo), il bianco dell’argilla, con tutte le sue implicazioni pratiche e artistiche.
Lo stesso vegliardo sottolinea come nell’antica Roma, per esempio, il porpora fosse appannaggio esclusivo dei più alti magistrati e dello stesso imperatore – non Giulio Cesare, per cortesia – perché quella tinta richiedeva una ricerca complicata e un procedimento lungo e costoso: impetrare lumi ai marinai e agli artigiani che rischiavano la ghirba per pescare i molluschi ‘porporofili‘ al largo dello stretto di Gibilterra e, in seguito, per produrlo con fatica e, come specificato, notevole dispendio.
Le brume e l’umidità delle lande nord orientali sono affascinanti, inquietanti; allo stesso tempo, avvolgono nel torpore – per qualcuno, uno scrittore, uno stato di grazia di cui si ha e non si ha coscienza – e stimolano alla riflessione sulle cose essenziali del mondo, nella speranza di giungere a stadi evolutivi avanzati.
Cromorama, vorrei esserne un cittadino; forse, lo sono già. Conoscere, nell’intimo, i colori, la loro natura, la loro teoria, la fisica e la chimica; riuscire a capire la sottile – o anche il contrario – differenza tra colori e tinte, la loro incredibile storia. Mi accontenterei (dovrei, dovrò), in alternativa, di leggere l’omonimo, dotto, documentatissimo saggio di Riccardo Falcinelli, grafico e designer, formidabile nel tracciare la traiettoria nei secoli delle amate nuance e la loro forza nell’incidere sul nostro umore, sulle nostre vicende, personali e collettive.
Mi accontenterei di inventare: un nuovo colore, conosciuti gli altri, donando voglia di ascolto e dialogo alla derelitta umanità.
Nelle mie divagazioni oniriche, viaggio di continuo attraverso il Giappone, non turistico, non esotico, non quello che da almeno due secoli scatena le insane passioni degli occidentali; vorrei deambulare per il Grande Yamato, ritrovarmi nei suoi arcani, venerare o, meglio ancora, ascendere/trascendere alla sua spiritualità di cui i complicatissimi riti sono solo la parte più visibile.
Aspirerei a diventare, dopo mille e mille prove, discepolo di Hokusai e Hiroshige, maestri, innovatori – nel solco della tradizione, ma con molte marce in più – pietre angolari di un modo originale di interpretare, di creare l’Arte; modelli inarrivabili per Monet, Van Gogh, Gauguin, per gli Impressionisti. Di questo è fermamente convinto Wahei Aoyama, fondatore a Tokio della galleria contemporanea A Lighthouse Called Kanata: “Il Sol Levante ispira ancora l’Occidente; dopo la seconda guerra mondiale eravamo cenere, ma dalla ricchezza del nostro passato siamo rinati“.
Nella nebbia penetrante, piccolo girasole nella notte, ruoto lentamente verso est, in attesa del nuovo Elio, che forse verrà.
A irradiarci tutti.