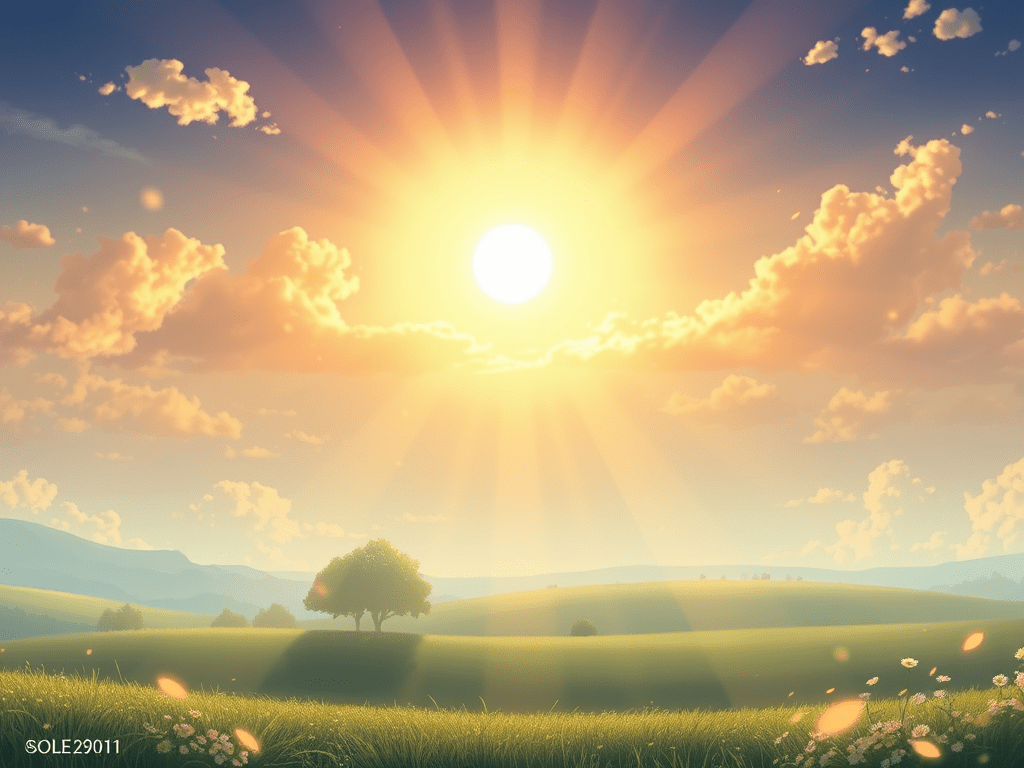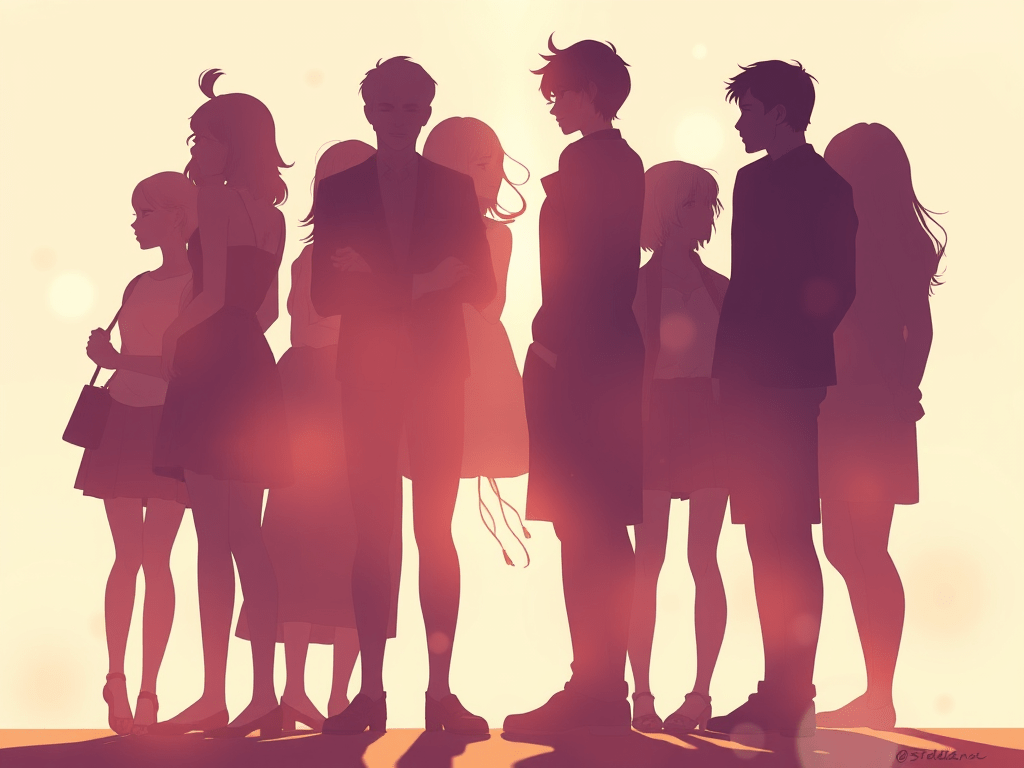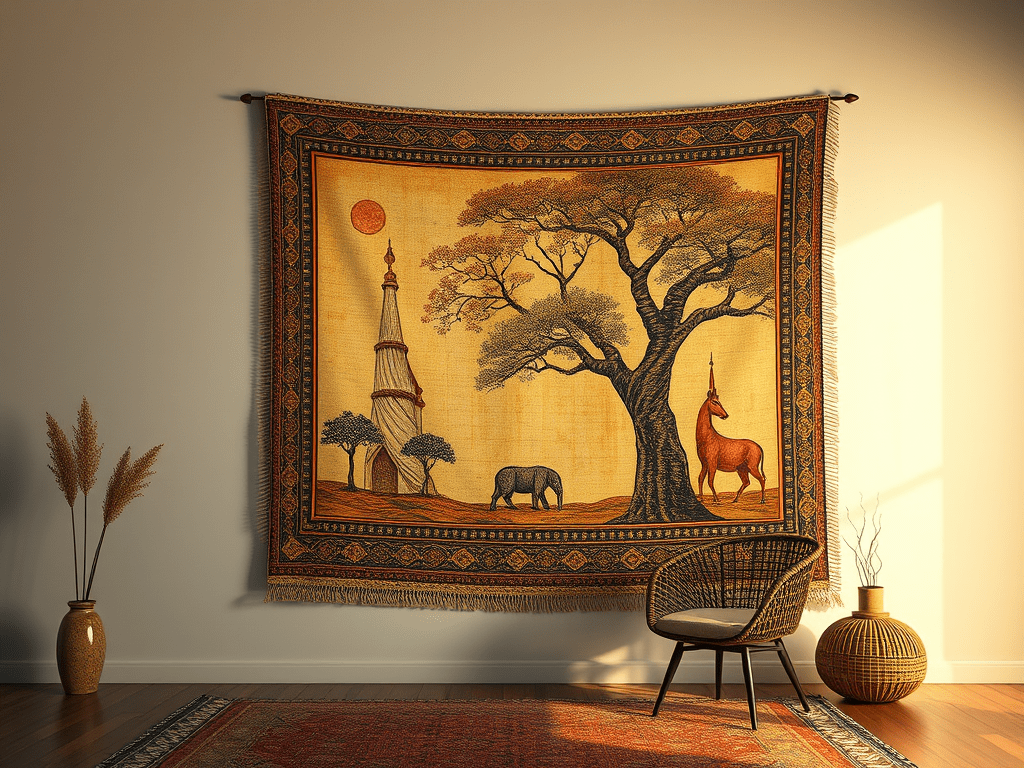Mentre il mondo brucia, noi accendiamo fuochi e ci illudiamo di salvarci.
Altro che diabolico complotto del dottor Fu Manchu (Peter Sellers, sempre cara mi fu questa pantera… rosa). Bagatelle tra educande, senza doppi sensi.
Crediamo che le mutazioni climatiche quasi irreversibili siano solo un astuto piano delle eminenze grigie per asservirci e impoverirci totalmente, quando accade l’esatto contrario, sotto i nostri occhi.
Saranno i mega fanta miliardari, coloro che arraffano patrimoni superiori a quasi tutti i bilanci dei vari paesi, a risolvere i problemi dell’umanità e della Terra; con i loro super poteri e con le loro super natiche. Senz’altro.
Un solo dato – tanto, chi ci crede? : 81 milioni di persone (persone?) lasciano sul Pianeta una impronta ecologica pari a quella di 4 miliardi e mezzo di sventurati. Ma sono solo fole.
Dal fatidico 1970 a oggi, le popolazioni di vertebrati sono calate del 60%; un milione (Marco Polo e Rustichello da Pisa non c’entrano, per la cronaca) di specie animali e vegetali è a rischio di estinzioni e poi non servirà l’intelligenza artificiale o qualche stupido algoritmo; due terzi degli uccelli al mondo sono polli (!); il 96% della biomassa dei mammiferi terrestri sono uomini (ominicchi) o animali allevati dall’uomo (mucche, maiali, capre, pecore). In teoria, per il sostentamento, nella laida pratica, per il profitto.
Che mai deve fermarsi, deve continuare imperterrito a fagocitare vite e risorse, senza pensare mai, nemmeno per sbaglio o per un attimo, al più piccolo risvolto etico.
Siamo occidentali, nordici, liberisti e siamo superiori. A chi, non è dato sapere, né è lecito chiedersi a quale disumana gara siamo iscritti.
Tutto questo e molto altro, molto di più ci racconta con dovizia di immagini e lucide parole Roberto Grossi, architetto e fumettista, attraverso “La grande rimozione” (per i tipi della Coconino Press); “Non riusciamo più a renderci conto della realtà“. L’autore sa collegare i puntini invisibili, come in quel giochino della Settimana Enigmistica; torna al macabro G8 di Genova (luglio 2001) quando devastazioni e uccisione di Carlo Giuliani furono eventi luttuosi, però in grado di riaccendere la coscienza civile e la voglia di lottare dell’opinione pubblica, dei popoli. “Ora al potere (come in un pessimo romanzo distopico, ndr) ci sono praticamente le stesse persone che nel 2001 hanno represso brutalmente i movimenti No Global, quando la gente chiedeva di invertire la rotta del liberismo che ci avrebbe portati alla catastrofe. La risposta è stata: vi massacriamo e tiriamo dritti. Al tempo lo hanno detto ‘solo’ a dei manifestanti, ora lo dicono sfacciatamente a tutto il mondo. E’ necessaria una rivoluzione culturale e per ottenerla servono sicuramente il confronto e il conflitto“.
Chico Mendes docet.
“L’ecologismo senza lotta di classe è giardinaggio“, disse senza fronzoli e senza retorica, il lavoratore, sindacalista e attivista ambientalista brasiliano. Sembra di udire nel vento la canzone dei Nomadi a lui dedicata:
… “Ma lunga sarà la strada e tanti gli alberi abbattuti
Prima che l’idea trionfi senza che nessuno muoia
Forse un giorno uomo e foresta vivranno insieme
Speriamo che quel giorno ci siano ancora.
Se quel giorno arriverà, ricordati di un amico
Morto per gli indios e la foresta, ricordati di Chico
Se quel giorno arriverà, ricordati di un amico
Morto per gli indios e la foresta, ricordati di Chico” …
Ci trastulliamo nel trionfo del nulla, però la Contea dei Sogni, Hollywoodland, e la Città degli Angeli, ardono come pire sacrificali;
i fiammiferi criminali siamo noi, ansiosi di tornare cenere – senza arabe fenici – quanto prima.