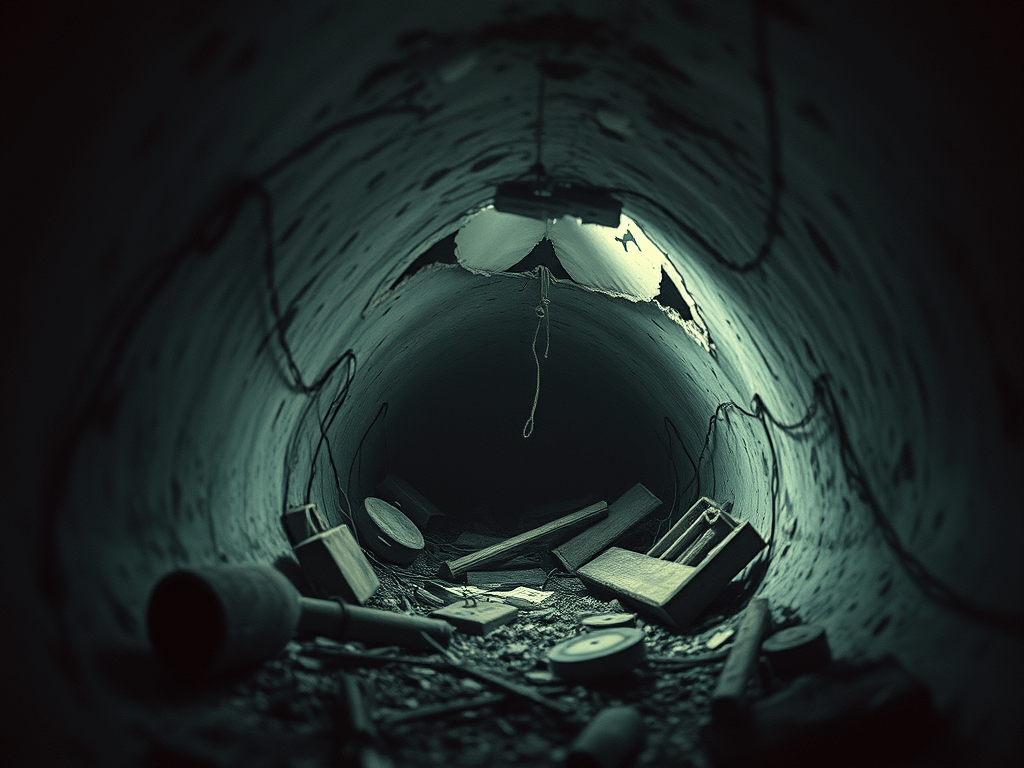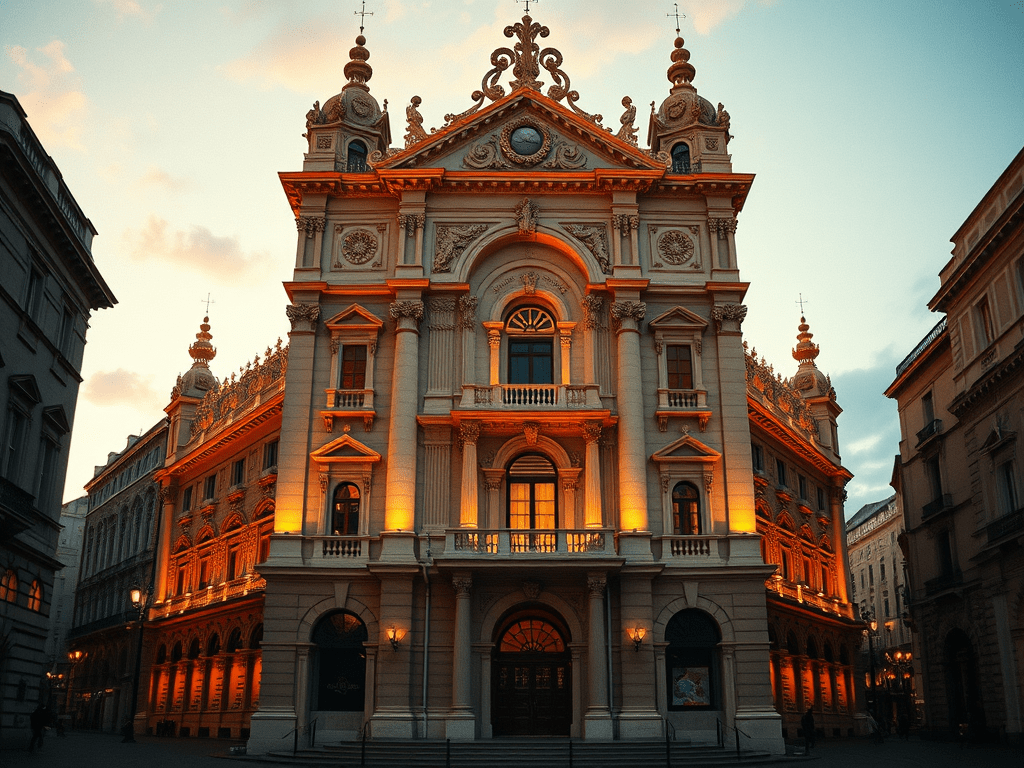Alexander Platz, cammino per le strade di Berlino.
Non c’è la neve, si vive come si può – non credo bene, almeno i mortali come me – non incontro Franco Battiato, Milva, Bertolt Brecht, Fabio Stassi.
Non in carne, ossa, intelletto; solo con l’immaginazione, dentro la mia mente: sì, per fortuna. La mia.
Molto spaziosa, la mia mente (del resto, è vuota), può contenere infinite persone, infiniti mondi.
Improvvisamente: siamo tornati non nel giardino della pre esistenza, ma nella Germania del 1933, in Bebelplatz. Dovrebbe rammentarmi qualcosa, dovrebbe risuonare un diapason sensibile al pericolo: imminente, terribile, letale.
Ho freddo, il gelo mi paralizza i pochi, scombinati pensieri; non conosco l’idioma germanico, ma qualcuno mi dice, ghignando: “Scaldati le mani al rogo dei libri“.
Sguardo inebetito, mi avvicino tremante alle fiamme. Guardo intontito migliaia di pagine, milioni di parole trasformarsi in tristi farfalle nere, poi in cenere. Non ci credo. Forse, anche per noi sarà così, forse, svaniremo in una folata di vento selvaggio.
Non comprendo la ragione, ma tremo di più, in modo incontrollabile.
Decine di migliaia di persone mi circondano, tutte recano libri, appaiono invasate e urlano: “Morte alla cultura, morte ai nemici e ai traditori della patria“. Dopo il rito fiammeggiante, un uomo tetro in divisa sale su un palco e arringa la folla: “L’uomo tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo di carattere“. Ovazioni, acclamazioni, applausi.
Mi allontano in fretta, come se la mia passione per le parole stampate fosse scritta – come confessione, come auto da fé – sulla mia faccia; come se la mia indole mi condannasse senza appello ad ardere eternamente al centro dell’Inferno.
Nemmeno un Pape Satan cui rivolgere una disperata richiesta di clemenza, nemmeno un povero diavolo per condividere l’incubo.
Il mio sguardo vaga ovunque alla ricerca di un segno, anche minimo, anche flebile, di speranza, ma nota con sgomento che perfino le opere di Emilio Salgari, “un volgare antimperialista internazionalista“, sono lanciate nel fuoco distruttore. Di sogni, di idee. Di domani.
Voglio ridestarmi, devo ridestarmi, non voglio vivere in un continente dove l’aria è ammorbata da miasmi di benzina e cenere.
Madido, ansante, afferro La linea della vita, nuova avventura di Corto Maltese: subito recupero energia e ottimismo.
Ancora scombussolato, tra me e me, sussurro: “Assurdo, impossibile. Ci siamo già passati“.
Fabio Stassi, però, dal suo libro più recente, mi ammonisce e mi dice:
“Rammenta le parole di Primo Levi: se qualcosa è avvenuto, può avvenire di nuovo“.