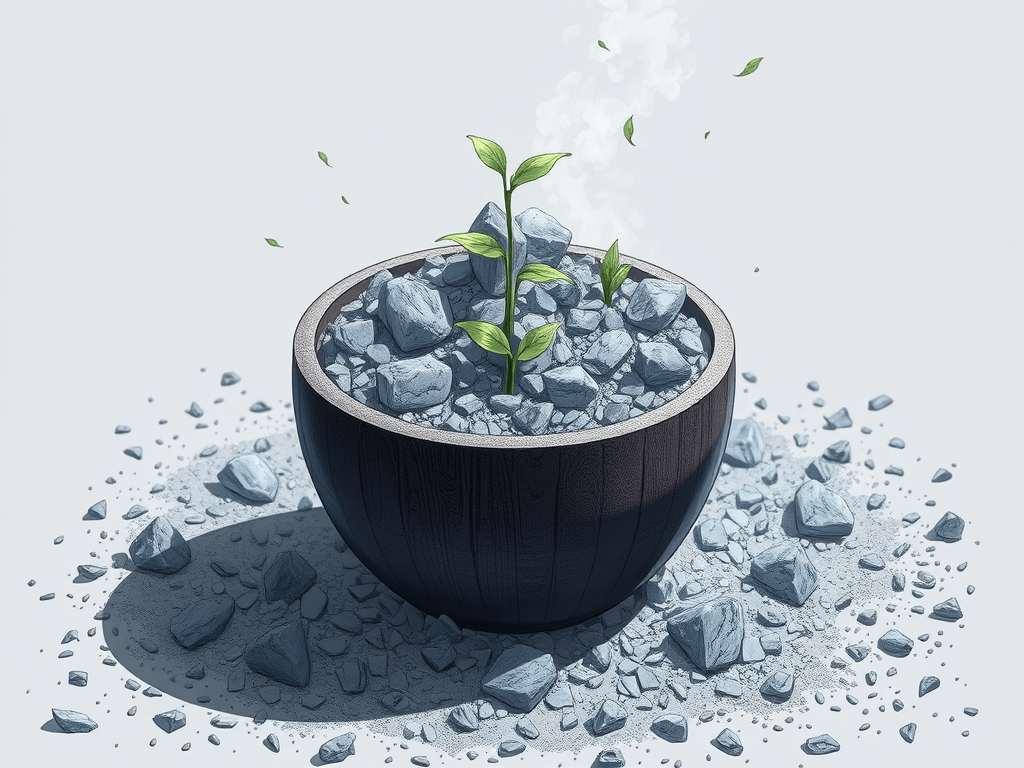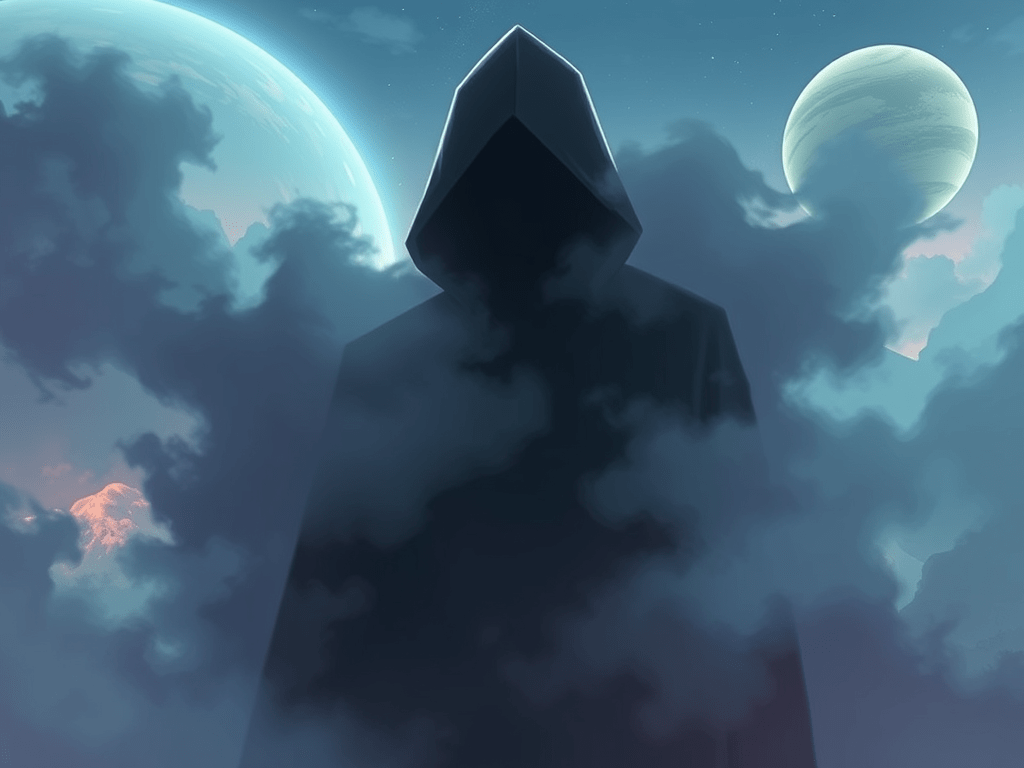Novembre incombe su di noi (molte nubi minacciose).
Mi correggo, si appropinqua: a falcate ampie e sicure.
Forse per questo motivo, mi sento κόνις, cenere; in greco antico (κόνις), sensazione – come direbbero i neo modernisti – contemporanea.
Siamo cenere, torneremo alla cenere: magari ce lo segniamo (previa gesti apotropaici), per non incorrere nella dimenticanza.
Il concetto è il medesimo – cinis, cineris – ma la derivazione, se preferite, l’etimologia, è latina. Alla faccia degli zombi, delle lingue ritenute, incautamente, morte.
Cenere, quella sostanza polverosa grigia che si produce in seguito a combustione di legna, carbone, carta e altri, svariati, innumerevoli materiali. Bigio, cinereo (non cine reo), cenerino (non canarino): tonalità di colore che somiglia alla cenere, come i miei vetusti capelli.
Tra i sinonimi, cenerognolo che non è un nano o il compagno furfante che conduce alla rovina – ridurre in cenere, annientare – burattini lignei, eppure parlanti. Altresì, potrei citare un’altra variante, non troppo allegra, né ottimista: andare in cenere, in senso letterale e anche figurato. Del resto, secondo la fede che va per la maggiore, è la fine cui tutti siamo destinati.
Con esiti diversi, magari, eppure, tanto per citare un titolo letterario: la fine è nota.
Un’urna cineraria, ideale, metaforica, ci accoglierà tutti, tappa intermedia, forse, prima di spiccare il balzo verso nuove, sconosciute destinazioni, dimensioni.
Lungi dall’assumere pose da artista tormentato, esistenzialista e transalpino – qualcuno potrebbe rammentare uno spassoso numero di Gigi Proietti – urge digitare che la cenere in realtà si presta ad usi assai interessanti: fertilizzante naturale, repellente per insetti e lumache, coadiuvante per la pulizia domestica, oltre a essere ricca di minerali (potassio, fosforo – servirebbe a certe/certi smemorati selettivi), calcio), per nutrire le piante e combattere l’acidità del terreno.
Penso al clamoroso furto ai danni di Napoleone (“tutti i francesi sono ladri? no, Bonaparte“…), rettifico, del Louvre e penso che con la cenere, gli audaci ladri – Arsenio Lupin o Lupin III? – potranno lucidare l’argenteria. In alternativa, lasciare cenere da masticare, amara, alle disorientate forze dell’ordine.
Panna montata, per innervare autostima e forza d’animo, ma monta anche la nostalgia: che tempi meravigliosi quelli della Pantera Rosa e dell’ispettore Clouseau. Per tacere dell’eleganza naturale e della signorilità di David Niven.
In una società sempre più “militarizzata e finanziarizzata“, la bulimia da energia, ci colpisce come un ciclone e presto ci affonderà, definitivamente; ce lo spiega bene Roberto Battiston, professore di Fisica sperimentale, presso l’ateneo di Trento. Astrofisico, nonché divulgatore appassionato e accattivante, ci parla di tutto, dalla creazione fino alla probabile “morte termica del cosmo“. Se possiamo osare, ci parla anche della cenere che resterà di noi e dopo i nostri disastri. “Dietro ogni pensiero, dietro ogni emozione, dietro ogni flusso di coscienza esiste un flusso di energia“. L’approccio dell’accademico non si limita agli ineludibili aspetti pragmatici, ma è anche filosofico, con in mente il bene comune, come approdo finale. Chi controlla l’energia, controlla il destino stesso delle comunità umane, ma, forse, non si rende conto che le società possono collassare “se eccedono la capacità di carico energetico del proprio ambiente“.
Battiston ci ammonisce con chiarezza, senza ricorrere a frasi ammiccanti o ipocritamente ottimiste, edulcorate: “Dobbiamo riallinearci con i flussi naturali di energia – sole, vento, acqua – in sinergia con gli ecosistemi, senza più accumulare stock di energia antica immagazzinata nelle rocce“. Potremmo vivere armoniosamente, con la Natura e tra di noi. Presto, subito.
Riabilitata la cenere, sarebbe sempre l’ora di riabilitare il consesso umano, perché, antichi modi di dire a parte (“Bacco, tabacco e Venere riducono l’uomo in cenere“…), o meglio:
urge che il consesso umano si riabiliti da sé, prima di auto annientarsi, possibilmente diventando comunità cooperante e ‘trasformandosi’ da padrone a custode della Natura.
Qualcuno lo ha già detto e scritto.