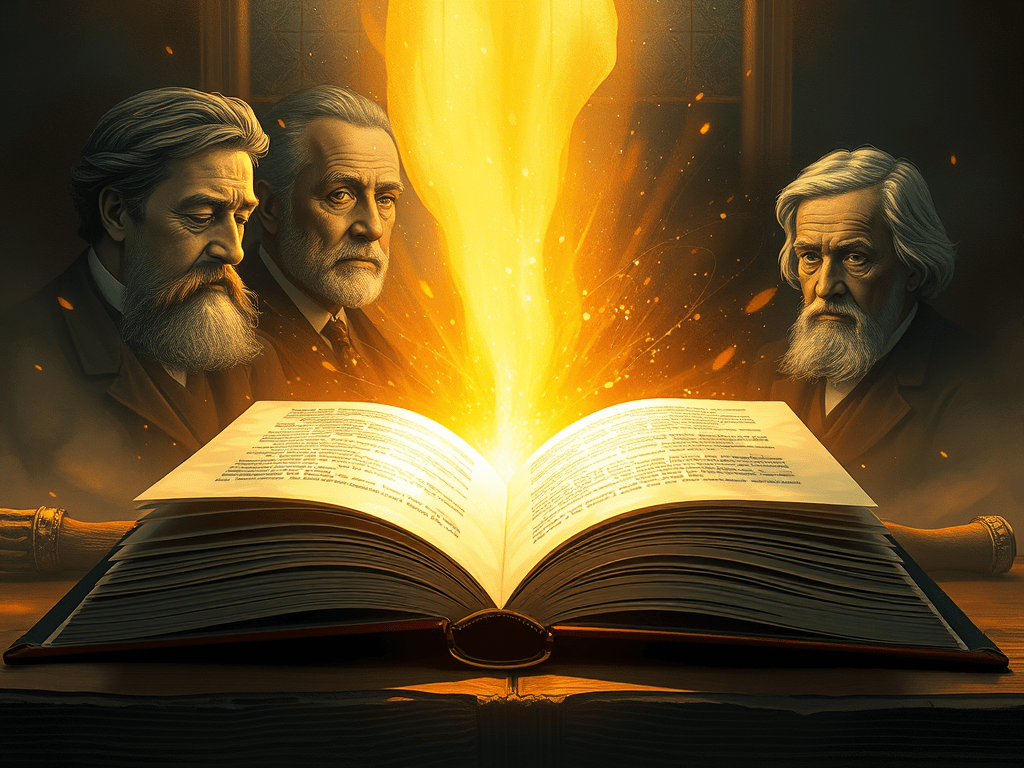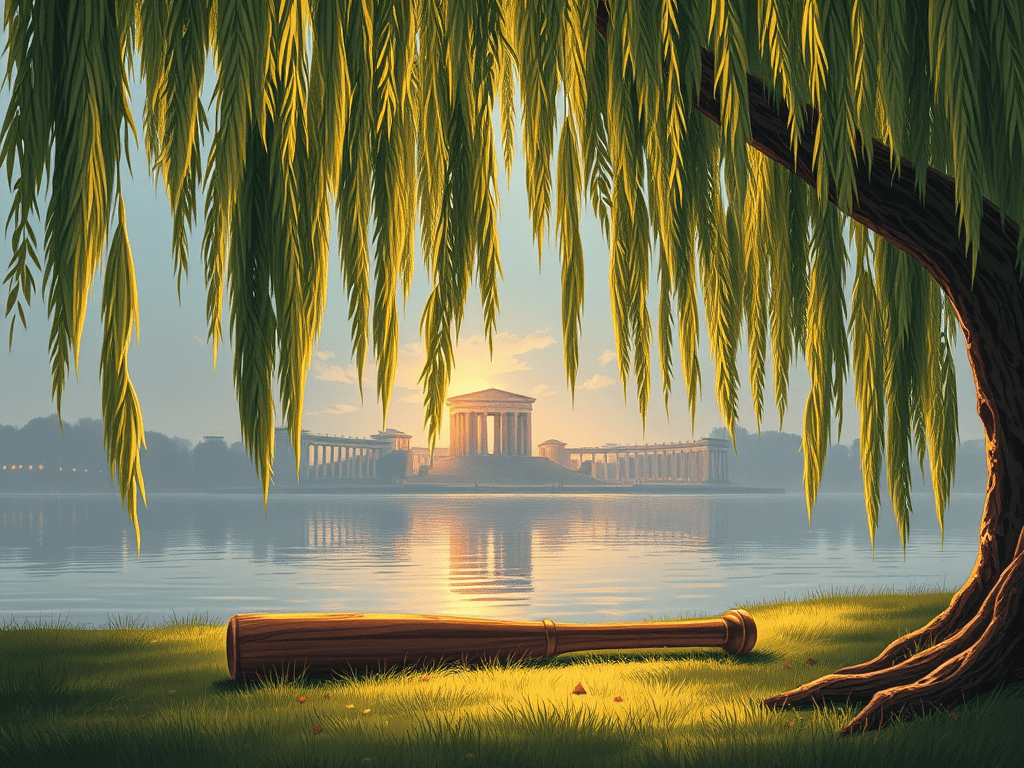Salire in alto, più in alto: fisicamente.
Si perdono i dettagli, ma, in teoria, la visione d’insieme, non dovrebbe sfuggire. Avete presente il film di una manciata di anni fa – perbacco, sono anziano – Piazza delle cinque lune, di Renzo Martinelli? Donald Sutherland, nei panni di un magistrato illuminato, pronuncia argomentazioni molto interessanti, al proposito.
Se l’operazione funzionasse anche a livello mentale, saremmo a cavallo; lasciando in pace l’equino, riceveremmo conferma che la materia grigia non solo è integra, ma funziona ancora. Nonostante tutto e tutti.
Sempre caro mi fu questo (codesto colle?) eremo sopra elevato, o erano le bianche scogliere di Dover? Fondo, mi confondo, forse passeggiavo con proverbiale, ontologica indolenza sulle sinuose, magnifiche contrade della Costiera, amalfitana, guardingo, per non finire triturato dall’incessante traffico: veicolare, inquinante, disumano.
La capa gira, per la veduta sontuosa, per l’inaffidabilità del povero cervello, ora sono sicuro – di cosa, poi, non saprei scriverlo – : era una terrazza abusiva sul Bosforo e io sognavo, trasognavo, mi cullavo con le dolci, splendide immagini di Costantinopoli – Bisanzio, per i fedeli alla classicità – e con le gesta (eroiche?), immaginarie, immaginifiche, illusorie, eppure reali, presenti, concrete, diverse e lontanissime dalle mie.
Belvedere, luogo tanto elevato, di derivazione latina – il lemma, non il luogo – da dove ammirare l’ameno paesaggio; così ameno (andrà tutto bene, scrivevano gli ingenui) che qualcuno ora invoca la presenza di vari Superman, per aggiustare un pochino le varie questioni mondiali. A parte il fatto che sarebbe una scorciatoia che non meritiamo: i gineprai li abbiamo creati noi, noi dobbiamo assumerci l’onore e la responsabilità di districarli. Per quanto concerne l’Uomo d’Acciaio, temo che dovremo accontentarci dell’ennesimo ritorno cinematografico, imminente; si sa, ormai, per lui (e, soprattutto, per noi, la realtà è più letale della kryptonite.
In alternativa, potremmo rivolgerci – filosoficamente, ma non solo – o potremmo vagheggiare di diventare super uomini, quelli teorizzati da Friedrich Nietzsche. Concetto tra i più fraintesi, equivocati, strumentalizzati della storia umana: in realtà, eterno ritorno – concetto della Grecia antica, tanto per gradire – e super uomo sono indissolubilmente connessi. Super uomo non rappresenta un supereroe di fumettara tradizione statunitense o un ariano nazista – peggio mi sento – ma colui che “è in grado di dire sì alla vita, come è in eterna ripetizione“. Non voglio, né posso ergermi a maestrino di quartiere, ma l’idea cardine del pensatore teutonico mi appare agli antipodi, lontana anni luce dalle sue degenerazioni, dai suoi sciocchi feticci.
Affacciato su un balcone in Costiera, osservo vulcani ritenuti spenti tornare in attività, colate laviche inarrestabili che ci spronano a ritornare, o a sposare, una nuova vita corale; non più monadi egoiste e orbate (cieche), ma persone che vogliono vivere e crescere insieme, socialmente e perfino politicamente.
Come scrive Roberto Mancini, professore di Filosofia teoretica presso l’ateneo di Macerata, “coralità significa che l’identità di singoli e comunità matura solo in dinamiche di comunione e ospitalità. E’ urgente rispondere alla pulsione sadico-paranoica dei poteri dominanti“.
Le sfarzose, arroganti, spadroneggianti nozze di Jeff Bezos, feudatario di Amazon, a Venezia; il decreto sicurezza dell’ipocrisia che trasforma la protesta pacifica in reato – Gandhi, Martin Luther King e Danilo Dolci inorridiscono – ; il boicottaggio con spregio della legge europea sul ripristino della Natura (compie un anno in questi giorni, è operativa e vincolante, non prevede lassi di tempo per essere recepita), sono solo lampanti esempi della sempre più sconfortante e perniciosa deriva.
Non vorrei un giorno, sempre più prossimo, guardare un’alba amalfitana, anche solo con l’immaginazione, da dietro le sbarre e a pagamento.